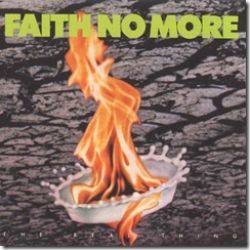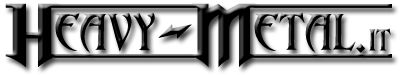In tempi in cui parole come download, streaming e myspace costituiscono l’ ABC del perfetto musicofilo, uno dei miei passatempi preferiti (e diciamo pure fra i più insani) resta quello di spulciare allegramente le bancarelle dei CD per la gioia dei venditori e del mio portafoglio; che siano quelle di un affollato centro commerciale, sotto il sole di un festival estivo o di una sagra di paese poco importa, è proprio in una di queste occasioni che, recentemente, mi sono reimbattuto in un un lavoro che ha letteralmente segnato un’epoca e in particolare la mia fanciullezza. Apripista, spartiacque, precursore, insomma, uno di quei dischi che fanno genere da soli e che si è tentato di definire nei modi più disparati. E la band che l’ha partorito, i Faith No More, non necessita certo di chissà quali panegirici. “The Real Thing” è l’espressione più pura del loro genio così avanti rispetto all’epoca in cui vide la luce. L’impatto che questo disco ha avuto sul metal e sulla scena rock in generale è stato enorme. In un attimo sono tornati alla mente i flash di una stagione memorabile: erano gli anni dei Guns n’ Roses e degli Skid Row, dei nuovi Aerosmith, gli anni in cui il grunge emetteva i primi vagiti, i Metallica si preparavano a dare il metal in pasto alle masse e gli Iron Maiden mostravano i primi segni di cedimento. Tutti contribuirono in qualche modo a piantare gli ultimi chiodi sulla bara dell’hair metal divenuto con gli anni simbolo di vacuità e di un’era che stava scomparendo. A un certo punto si presenta questa band stravagante, con il cantante che veste Body Glove e bermuda, il chitarrista tutto barba e capelli, un tastierista estroso, una sezione ritmica eclettica. “Epic” e “From Out Of Nowhere” intasavano i juke box in quell’estate del 1989. Era qualcosa di nuovo, di mai sentito e forse atteso da tempo. Sono proprio i brani in questione assieme alla hit “Falling To Pieces” a costituire un tris di assoluto livello, un overture che ci introduce nell’ universo di questi schizzati californiani e che li catapulta direttamente nella leggenda. Il miagolio di Mike Patton, i fraseggi intrisi di feeling forgiati da Jim Martin, un chitarrista che con poche note riesce a dire più di tanti fantomatici guitar hero, un tastierista un po’ kitsch e una sezione ritmica pulsante e dinamica. I Faith No More restano ad oggi l’espressione migliore di quello che oggi definiremmo crossover, una strana miscela di stili in cui nessuno componente della band prende il sopravvento ed ogni strumento è esattamente distinto, riconoscibile e indispensabile. Senza uno solo di questi tasselli, ci troveremmo davanti un’altra band (come i fatti dimostreranno in futuro), non necessariamente migliore o peggiore.
Passata la carrellata iniziale di hit, c’è un lato onirico che prende il sopravvento, quello di “The Morning After” e dell’ ipnotica title track, in cui il talento di Mike Patton si manifesta in tutta la sua grandezza sperimentando varie soluzioni stilistiche. Discorso a parte merita la strumentale “Woodpecker From Mars”, sorta di prova corale della band che partorisce un accattivante ed imprevedibile mosaico sonoro. Persino una cover come “War Pigs” che nulla toglie e nulla aggiunge all’originale, assume una veste tutta nuova, sorta di spartiacque fra il sound tradizionale dei Black Sabbath e un presente che sfugge ad ogni facile catalogazione.
I brani di “The Real Thing” hanno tutti la caratteristica di essere orecchiabili e lineari ma ad un ascolto più attento lasciano esterefatti per la profondità e per come amalgano le cinque anime differenti dei musicisti. Come dicevo all’inizio, è un disco che ha segnato un’era e ancora a distanza di vent’anni mantiene intatto il suo fascino borderline, autentica dimostrazione vivente di come si può sconvolgere il mondo del rock partendo dal basso, senza fare troppo rumore ma con tanto genio nelle vene.
Faith No More – The Real Thing