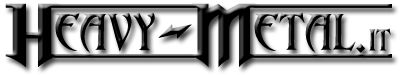Ormai propria di pochi, la capacità di riuscire a forgiare un’opera spiazzante e non ordinaria mantenendo comunque fascino sull’ascoltatore, in ambito musicale, è quantomeno sintomo di capacità, gusto e straordinaria coordinazione interna. Qualità, insieme a miriadi di altre, facenti parte del bagaglio dei Misery Signals che, dopo l’ottimo esordio, tornano con quella che riesce a rivelarsi la migliore uscita dell’anno in ambito “core”.
Chi legge dimentichi cloni di tutto ciò che ha il sapore di Svezia, produzioni pompate in stile nu, ritornelli emo e tutte le caratteristiche che hanno sancito saturazione, omologazione e conseguente antipatìa del metalcore. Qui il genere è rivisto sotto chiave personale e, udite udite, originale dosandosi un pò alla volta col volgere della tracklist e scatenando una presa magnetica.
Un album non per tutti, dunque, che entra in circolo col macinare degli ascolti causa il suo fare imprevedibile e strutturalmente asimmetrico. I brani, pur mantenendo un marchio di fabbrica ben definito, godono di vita propria e valore a sè stante, offrendo ognuno nuovi spunti e motivazioni per apprezzare l’opera. Il risultato è qualcosa di heavy ma emotivamente elevato, frenetico ma poetico, non sempre accessibile ma ipnotico. Si immagini la dinamicità ritmica e strumentale degli ultimi Coprofago e dei Meshuggah più riusciti che incoccia, coagula e si scontra con la “sporcizia” degli Unsane, l’imprevedibilità dei Dazzling Killmen, il post-rock ed il meglio del bagaglio metalcore in una miscela perfettamente coesa. I brani risultanti sarebbero quelli di “Mirrors”. Pezzi obliqui che di regolare hanno l’irregolarità e la sorpresa di alternare con un collante mostruoso il feroce groove del cyber-thrash, cambi di tempo eccezzionali per gusto e precisione, armonizzazioni di tradizione noise, tonnellate di melodìe, arpeggi, passaggi acustici ammalianti e passaggi in clean vocals mai forzati che lasciano prendere fiato dall’espressivo e vitriolico growl di Karl Schubach. Mai una caduta di stile, mai un break che riesca a non piacere, nonostante una spregiudicatezza ed una naturalezza sfrontata e sincera nell’esprimersi. In un contesto del genere, non poteva estraniarsi la produzione di Ben Schigel, che aveva l’arduo compito di ereditare il lavoro di Devin Townsend sull’esordio e riesce a comportarsi ottimamente grazie ad un sound pieno ma volutamente sporco che porta alla mente le ultime produzioni dei Tool. L’ennesimo valore aggiunto ad un’opera fantastica nel suo essere indipendente e determinata, capace di catturare cuore e neuroni di chi avrà la fortuna di trovarsi sulla sua strada. Da avere.