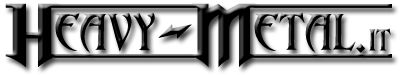Ci sono casi nella vita in cui, davanti ad un disco, il metallaro che si rispetti deve accettare in tutta coscienza di abbandonare i propri preconcetti, i propri schemi, e accettare che la musica proposta dipinga i propri colori senza venire tarpata o annacquata da giudizi affrettati. Questo è stato il mio caso davanti alla quarta opera dei russi Psilocybe Larvae: un disco assolutamente complesso e non immediato, al quale è importante dedicare più e più ascolti. I nostri sono reduci di diversi cambi di formazione, che rendono questo ultimo lavoro ancora più notevole, in quanto unicamente figlio della volontà e dell’inventiva del cantante/chitarrista Vit Belobritsky, il quale nonostante i momenti difficili passati dalla band è riuscito nel corso di circa 3 anni dal precedente lavoro “Non-existence” a partorire un lavoro del genere.
Ma veniamo al dunque: “Labyrinth of penumbra” ci trasporta in un mondo decadente e malinconico, dominato da una persistente sensazione di angoscia e solitudine, accentuata dalle molteplici aperture melodiche sparse lungo il viaggio. Trattandosi di un concept, è fondamentale approcciare l’ascolto del disco osservando attentamente l’artwork nei suoi molteplici dettagli, tra i quali spicca il flusso di anime luminose all’ingresso del labirinto, il cui andamento rassegnato ci accompagnerà per mano durante tutte le 9 tracce: con la opener “Soul trekking”, le anime entrano nel labirinto perdendo fin da subito ogni speranza, percepita solo negli spasmi del chorus della canzone, con vocals alternate tra scream e puliti che ricordano un po’ i Texture. Sebbene si avverta fin da subito la vena progressiva dell’opera, a volte dei cambi di tempo troppo netti rendendo leggermente discontinua l’attenzione nei confronti della narrazione. Si passa quindi alla oscura “Haunting”, dominata da ritmiche più incalzanti e da un incedere molto più violento nelle strofe: unica pecca forse è proprio il synth iniziale, non di qualità eccelsa che rende un po’ “plastica” un’introduzione comunque ben riuscita. Il pezzo culmina in un finale piovoso, che ci permette di rilassare le orecchie per quello che può considerato il pezzo più catchy dell’album, “Shining Shambhala”. L’arpeggio in apertura porta l’ascoltatore ancora più verso il centro buio del labirinto, mentre il chorus regala un’epicità inaspettata in un disco del genere, molto apprezzata da scrive. Insolito ma azzeccato il riferimento al Shambhala, termine che identifica nella cultura indiana un luogo di pace, tranquillità e gioia, che l’anima narrante del brano definisce come suo personale, collocandolo alla fine del proprio viaggio. Se questo brano mette voglia di essere cantato, il brano che segue è da pogo. In “Trial by fire”, il fuoco viene avvertito attraverso un riff iniziale azzeccatissimo che attira immediatamente l’attenzione dell’ascoltare e lo spinge nel primo minuto di canzone al pogo più sincero. Purtroppo, l’insieme perde spinta e convinzione nel corso della canzone: se da un lato la vena prog aiuta ad inspessire la trama dell’opera, dall’altra taglia le gambe al lato più death dell’album, non dando mai completamente tempo all’ascoltatore di galvanizzarsi e prendere il ritmo.
Nonostante questo lieve calo, “Into the labyrinth” ritorna in carreggiata, rimanendo su un mid tempo più consono alle abilità della band, che sembra muoversi più agevolmente su momenti più atmosferici, nonostante le abilità tecniche di tutti gli strumentisti siano ineccepibili. Molto piacevole è l’arpeggio iniziale poi richiamato in coda al brano, che ci porta al cospetto della fortezza del tempo (preceduta da un interludio strumentale), terzultimo brano del viaggio: il brano alterna come i suoi predecessori, momenti di netta violenza (bello il riff tra i momenti parlati carico di groove) ad attimi di calma, intricandosi in un dedalo di cambi con finalmente le tastiere a sorreggere l’azione della chitarra che molto spesso ho sentito trovarsi da sola ad affrontare la responsabilità della narrazione. Come sempre la traccia riesce nel suo intento, ma ammetto che la voce che da cantante diventa quasi narrante sia abusata in quest’album, così come troppo spesso i pattern di note della chitarra diventino ostinati al limite del fastidio, sia nei riff che negli arpeggi. Questa sensazione si ripercuote dal finale di “River of remembrance” al pattern di apertura della finale “No escape”, che chiude un album che senza il proprio booklet non avrebbe la stessa sostanza: avrei apprezzato nonostante tutto un briciolo in più di immediatezza.
Questo “Labyrinth of penumbra” è un album che anche dopo una decina di ascolti, senza cercare nel profondo dei testi non sarei riuscito a far andare oltre la complessità di una struttura che a volte si regge in piedi ed a volte fa smarrire e disorienta l’ascoltatore…
…ma d’altronde anche un labirinto è concepito per disorientare, no?