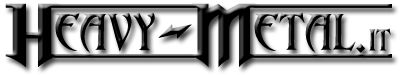Giunto al terzo full length (senza quindi contare un EP e un paio di partecipazioni a compilation), il four piece svedese è ormai una macchina ben oliata: infatti nessuna defezione o avvicendamento si registra in lineup fin dal primo omonimo disco del 1995 (uscito per Musea). Una brevissima retrospettiva, vista la scarsa notorietà della band, mi pare quantomeno utile, se non altro per dar conto di una considerevole svolta sonora rispetto al passato. La chiamo ‘svolta’, per ora, senza connotare il termine in un senso o nell’altro… il perché si comprenderà al termine di queste righe.
Si diceva dell’omonimo: scovato per caso nell’usato, e acquistato ricordando buoni pareri letti su riviste cartacee, il disco mi aveva molto ben impressionato. Pur senza sconvolgere per apporto innovativo – e ciò va rimarcato e ribadito a scanso di qualunque equivoco su ciò che passa, spesso solo per convenzione, sotto il nome ‘prog’ – questi ragazzi si erano resi artefici di una fresca e accattivante rielaborazione di Yes (saccheggiati a piene mani) e Gentle Giant (che facevano capolino in qualche struttura corale), condita da percussioni etniche, da melodie azzeccatissime e da qualche momento di autentica e divertita caciara… insomma, un lavoro gradevole e a mio avviso riuscito, che dà conto della (peraltro esigua) vitalità residua del movimento ‘new prog’, quella galassia di band che troppo spesso ripercorre stilemi e sonorità dei bei tempi andati con risultati (se non talora addirittura intenti) quasi esclusivamente manieristici. Niente nomi, solo cognomi: Spock’s Beard, Pallas, IQ, Arena, Flower Kings, e qualche altra decina.
Il loro secondo cd, “Superb Birth” del 1999, è un momento di transito da soluzioni lato sensu ‘progressive’ ad altre più marcatamente hard, e con sempre più numerose strizzate d’occhio radiofoniche… e questa è, in sostanza, la proposta dei Ritual in questo “Think Like A Mountain” (titolo carico di suggestioni un po’ ecologiste e un po’ intimiste, come si evince da alcune righe lette sul loro sito).
E’ vero, non mancano i riff spezzettati e dissonanti tanto cari alle band dei Seventies, così come non si rinuncia ai timbri ‘vintage’ (i proverbiali Hammond, violini distorti, flauti à la Anderson, allegre schitarrate acustiche e quant’altro); ma in tutto ciò ora si insinuano suoni freddi di synth e voci filtrate, e chitarre talvolta impegnate in riff anche piuttosto hard. Sull’impasto risultante squilla decisa la voce di Patrik Lundström, cantante estremamente versatile (lo scopro anche impegnato in un progetto pop) ed espressivo, che – lo dico senza paura di destare scandalo – facilmente potrà ricordare, almeno a tratti, un certo Robert Plant.
La struttura dei pezzi (il più lungo dei quali è di appena sette minuti, a ulteriore testimonianza dell’opera di ‘sfrondamento’ in atto) è equilibrata e attenta alle dinamiche, le quali ultime appaiono messe nella giusta luce da scelte tanto timbriche quanto di arrangiamento sufficientemente varie, senza peraltro mai risultare pretestuose. Gli strumentisti sono senz’altro all’altezza, e ciò si percepisce adeguatamente malgrado la (sacrosanta) scelta di bandire qualunque forma di overplay.
Nell’immediato, balzano subito all’orecchio brani come l’opener “What Are You Waiting For”, che esordisce con accenti arabeggianti, trasita per un saltellante riff à la Yes, per risolvere in un memorizzabilissimo refrain; o come “Humble Decision”, dal piglio da hit-single, con una malinconica melodia di ispirazione brit (qualcuno ha detto Verve?), e “Once The Tree Would Bloom”, con percussioni a far da tappeto ad una gioiosa ballata acustica, impreziosita dall’ennesima, trascinante linea melodica (nel medesimo spirito di “The Way Of Things”, uno dei brani più rilevanti presenti sul primo disco).
E’ forse ora giunto il momento di colorare il termine ‘svolta’, lanciato all’inizio e che ora ritorna e domanda spiegazioni. Lascio quindi da parte la distaccata descrizione fin qui condotta, ed esprimo un giudizio positivo solo in parte, tanto in relazione all’evoluzione del sound del gruppo quanto per la qualità del nuovo materiale: sotto il primo profilo, la parziale virata da un (mi si passi il termine) “prog’n’roll” in stile Spock’s Beard a beneficio di sonorità più commerciabili e suadenti, dà alle mie orecchie un senso di ibrido malriuscito, che non sa né di mandarino né di pompelmo… a questa stregua, meglio dedicarsi decisamente a un suono o ad un altro, senza riserve. Se operazione ‘commerciale’ voleva essere, non è quindi certamente delle più astute. Il tentativo, comunque, è di certo apprezzabile, svecchiando almeno un po’ una proposta nata, in un certo senso, già morta.
E qui arrivo (concludendo) al secondo aspetto: non siamo in presenza, questo è certo, di un disco che sa di perizia calligrafica, e ciò va a sicuro merito di questi svedesi. E’ peraltro da notare come, forse, non sia ormai neppure sufficiente apparire meno inutilmente derivativi per rivitalizzare il new prog, una nicchia che da troppo tempo ormai si alimenta per autocombustione, distogliendo (anche grazie alla scaltrezza di etichette non major, ma sicuramente molto solide, che starnazzano ai quattro venti ogni presunta ‘new sensation’ sostanziata di risciacquatura di piatti) l’attenzione da ciò che di assolutamente vitale esiste nell’universo progressivo.