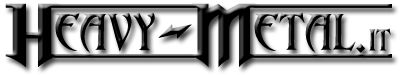L’ultima fatica in studio degli Spock’s Beard costituisce un inedito per il gruppo, trattandosi di un vero e proprio concept album: mai prima d’ora, infatti, la band americana si era cimentata – proprio per una personale contrarietà all’idea di album ‘a tema’ – con un canovaccio già ampiamente sfruttato nella storia del rock, a partire da nomi che sono già quasi leggenda quali Who e Genesis (mi riferisco, in special modo, a ‘Tommy’ e a ‘The Lamb Lies Down On Broadway’).
Il lettore più attento avrà certamente notato (e se ne sarà probabilmente stupito) l’aggettivo con cui iniziano queste righe. In verità non si tratta di una svista: anche se gli Spock’s Beard proseguiranno la loro carriera, è ben difficile credere che, privi (come sarà già ben noto) di Neal Morse, il loro stile non incontrerà la benché minima trasformazione. Il venir meno di una figura dotata di così grande senso melodico e di altrettanto spiccata capacità nell’arrangiamento (che è da sempre uno dei punti di forza del sound delle Barbe), non potrà quasi certamente passare indenne all’esame di un ipotetico nuovo lavoro del gruppo. Ma torniamo al presente.
La mole del lavoro in questione (quasi due ore di musica) non deve scoraggiare: la mistura di AOR tipicamente a stelle e strisce con omaggi continui alla grande stagione del progressive rock di Yes, Genesis, Gentle Giant e altri, a cui gli Spock’s Beard sono avvezzi sin dagli esordi, è fluida come quella dei loro momenti migliori, e sempre appassionata e ‘gustosa’ negli arrangiamenti. Mi piace citare, fra le contagiose melodie disseminate qua e là nel disco, quelle di “Long Time Suffering” e di “Wind At My Back”, nel tipicissimo stile Beard; e ancora, a spiccare fra momenti più distesi – pur doverosamente presenti in un lavoro tanto lungo -, la trascinante “Devil’s Got My Throat”, che pare studiata per esser cantata a squarciagola in una serata di divertimento e casino.
Le circostanze in cui i brani di questo album sono stati composti sono le più varie (dal tour bus – nel caso di “Carie” – ad un mattino all’alba ad Albuquerque), e questo dà senz’altro conto delle numerose escursioni di intensità che si presentano all’ascoltatore. Ricomposte ad unità, a fare da colonna sonora al viaggio interiore di un uomo dotato del potere di guarire (e che ripercorre, almeno idealmente, il cammino di Neal Morse verso la sempre più intensa considerazione delle proprie istanze spirituali), formano un tutto a mio parere molto più convincente rispetto alle precedenti prove in studio (in particolare rispetto ai due album precedenti).
“Quando è rock è più rock che in passato, quando è soft è più soft, e le parti intricate sono ancora più intricate”: è lo stesso Morse a fornire questa incisiva descrizione dello stile complessivo di “Snow”. Un album quindi, come traspare anche da queste parole, che nulla aggiunge o toglie a quanto già detto e dimostrato, ma che estremizza (ed in modo, lo ripeto, a mio giudizio riuscito) tutte le componenti che da sempre caratterizzano l’approccio stilistico del quintetto. E come non era giusto considerare i precedenti lavori come capolavori del rock di tutti i tempi (come si è lanciato a fare anche l’illustre Mike Portnoy), altrettanto va ora detto riguardo a “Snow”, disco tecnicamente e formalmente quasi inattaccabile ma ideato e realizzato (almeno così vorrei pensare) esclusivamente come risposta alla grande passione di questo drappello di eccellenti musicisti, e pertanto libero da qualsivoglia intento di ‘rivoluzione’ o di radicale evoluzione sonora… o, come alcuni direbbero, di ‘progressività’.
Come già accennato, è di tutta evidenza il fatto che si apra ora, per gli Spock’s Beard, un nuovo ciclo: tenendo a mente questo, quindi, non è forse azzardato considerare ‘Snow’ come il miglior momento della loro carriera, per tutti i motivi suesposti. Chi si accosterà alla band a partire da questo disco, ritengo, non rimarrà deluso; altri invece (e mi metto fra questi) avranno un po’ di nostalgia per prove di meno ampio respiro ma forse più fresche e meno ‘ruffiane’, perché uscite in tempi non sospetti quanto a popolarità (implicito è il riferimento a “The Light” ed a “The Kindness Of Strangers”, senza peraltro dimenticare anche il validissimo “Beware Of Darkness”).
In qualunque modo, però, al momento della prossima uscita del combo statunitense, sarà difficile che ciascuno di coloro che li hanno amati o anche solo apprezzati non senta la mancanza di quel simpatico istrione (un’autentica forza della natura sul palcoscenico, e chi ha visto può confermare) grafomane, che a volte – prendendo in considerazione anche progetti solisti e Transatlantici assortiti – pareva condannato a far uscire, per ogni ora di musica, un unico minuto realmente ispirato. Stavolta però (sarà forse merito di un aiuto dall’alto?) il buon Neal Morse, pur senza aver dato vita a un album indimenticabile, ha certamente aumentato il rapporto di 1:60 di cui dicevo… tutto questo rappresenta davvero la chiusura di un cerchio? Sentiremo in futuro…
Spock’s Beard – Snow