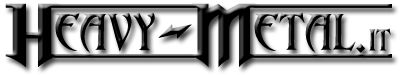Ascoltando i Today Is The Day, talvolta, viene da domandarsi se la concentrazione di psicotropia e lacerazione contenuta nei loro dischi abbia un qualche tipo di senso. Se “Temple Of The Morning Star” è l’opera più completa di Austin e compagni di clinica, lontana dalle derive avant-metal di “In The Eyes Of God” e dall’alienazione completa di “Sadness Will Prevail”, probabilmente una chiave di interpretazione esiste, nascosta in nanosecondi di lucidità, tra qualche arpeggio minimale o in frasi che non siano sconnesse o grottescamente volgari.
Si potrebbe liquidare “Temple Of The Morning Star” come una sorta di breviario dell’hardcore e del metal più contaminato, intervallato da brevi loop sperimentali senza capo né coda, persi tra rumore bianco e autocompiacimento. Prendiamo “Pinnacle”: attacco di batteria scarno e ficcante, poi un giro di basso irresistibile, entra a questo punto la voce perennemente filtrata e urlata di Steve Austin che recita una sorta di mantra del sesso estremo, poi il brano prende forma, striscia su sentieri fangosi ma sempre controllati e ad alto tasso tecnico (la sezione ritmica devastante e straordinariamente duttile è sempre stata marchio di fabbrica indelebile di ogni produzione targata Today Is The Day).
Il brano che precede “Pinnacle” (“Mankind”) è in parole povere un esperimento che non sfigurerebbe in qualche ignomia dei Mortician: sopra la trasposizione di un film horror nel quale si odono una bambina ed una ragazza discutere sommessamente e con tono patetico, parte un giro di chitarra acustica dal vago sapore malinconico, poi Austin prende a blaterare con fare isterico, quasi demenziale. Un alternarsi continuo di pezzi che hanno una forma compiuta tra metalcore tecnico iper-violento ed iperrealista (“Blindspot”, “Kill Yourself”) e derivazioni iniziatiche che sono l’estensione di un ego non del tutto “stabile” (“The Man Who Loves To Hurt Himself”, “Satan Is Alive”, “Hermaphrodite”). Ognuno è libero di farsi l’idea che ritiene più consona alla propria personalità sul disco in questione. Ma se io (e, per dovere di cronaca, molta “critica musicale non allineata”) lo ritengo una delle opere più importanti e struggenti degli anni ’90, è perché le tracce iniziali e finali (“Temple Of The Morning Star” e la sua “ripresa”) sono un lamento dall’intensità quasi intollerabile: “I Can’t Be What You Want Me To Be, I Am Dead”, ripete all’infinito un’Austin stralunato e tesissimo, a testimonianza che lui nel dolore non prova piacere, non lo spettacolarizza gratuitamente, ma lo subisce come tutti noi. Lo esorcizza, probabilmente, e se è oggettivamente impegnativo ascoltare “Temple Of The Morning Star” dall’inizio alla fine, se ne esce in qualche modo spossati, ma gratificati. Un’opera di sublime bellezza, insomma.
Una cover di “Sabbath Bloody Sabbath”, del tutto fedele all’originale, è posta come traccia fantasma: significa che “Temple Of The Morning Star”, col metal, ha molto a che fare, assai più di quello che si possa credere ad una visione superficiale.
Today Is The Day – Temple Of The Morning Star