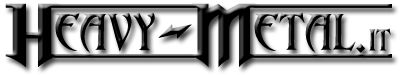Sono dovuti trascorrere più di 25 anni per poter calcare nuovamente lo stesso palco e realizzare un album assieme. Antichi dissapori veramente superati o una reunion perchè al momento è la soluzione più semplice ed economicamente soddisfacente? In ogni caso questo ritorno al passato sembra la soluzione più ovvia dopo il divorzio dei fratelli Van Halen dal cantante Sammy Hagar e dallo storico bassista Michael Anthony (rimpiazzato da Wolfgang Van Halen, figlio di Eddie), e la carriera solista di David Lee Roth negli ultimi anni sempre più in calo. Ad ogni modo, dopo tanti rinvii dovuti soprattutto alla salute precaria di Eddie (ha dovuto lottare contro il cancro e problemi di alcolismo), i Van Halen sono riusciti a pubblicare l’atteso disco in studio dopo tanti anni di silenzio discografico.
Ma passiamo all’album. Innanzitutto la cosa che si nota rispetto all’ultimo lavoro della band periodo Lee Roth, “1984”, è che non ci sono più tastiere, quindi il sound è generalmente più vicino alle prime produzioni della band. Nessun modernismo, a parte solo la registrazione che dà un colore più vivo, più attuale, al classico sound vanhaleniano. Un ritorno al passato quindi. Addirittura ci sono ripescaggi di composizioni da vecchi demo e outtake.
Tattoo, opener dell’album, è infatti in parte un rifacimento di un vecchio pezzo, “Down In Flames”, song suonata dal vivo nei club a inizio carriera, mai pubblicata su album. Primo singolo, “Tattoo” ha diviso i fans, chi la considera un gran pezzo, chi si aspettava di più dopo così tanto tempo. Fin dalle prime note si sente che i Van Halen sono tornati a fare quello che gli riesce meglio: big rock senza fronzoli, potente e melodico. Fin dal primo ascolto il pezzo risulta molto orecchiabile, forse il punto debole è proprio il ritornello eccessivamente ripetuto che a più ascolti annoia. Il resto scorre piacevolmente e il solo ci riporta Eddie allo smalto dei tempi migliori. Anche la voce di David Lee Roth appare non troppo scalfita dal trascorrere del tempo, anche se non si può dire sia proprio allo stesso livello degli esordi, soprattutto per quanto riguarda i registri acuti.
Subito a seguire She’s The Woman, interamente pari pari alla versione del primissimo demo dato agli esordi nelle mani di Gene Simmons. Pezzo classico del sound Van Halen dei primi due album con ritornello di presa immediata.
You And Your Blues parte soffusa con chitarra e la voce sorniona di David, poi nel pre-chorus e chorus c’è un buon contrappunto di voci che rende la song tra i pezzi più radiofonici insieme a “Tattoo”.
China Town, insieme a “Bullethead” e a “As Is” forma il trittico più hard dell’album. Chi si sarebbe aspettato dai Van Halen brani ancora così tirati? In “China Town” l’intro di chitarra in tapping richiama subito alla mente quello di “Hot For Teacher”. Poi il pezzo si snoda come un boogie velocissimo sempre stile “Hot For Teacher”. Il solo di Eddie risulta davvero pregevole, forse il più vistoso dell’intero album.
Blood And Fire è un altro vecchio pezzo recuperato, dallo strumentale “Ripley” del periodo “1984”. Fin dall’inizio richiama nettamente pezzi alla “Little Guitars” da “Diver Down”, col suo incedere spensierato e solare e il ritornello azzeccato.
Bullethead è breve e tirata col ritornello nel quale viene citato il titolo dell’album.
As Is parte con un intro di batteria e dopo un riff possente cadenzato, il brano si sviluppa come “China Town” in un boogie – hard rock sfrenato. Viene da chiedersi se ’sti signori rockers abbiano veramente passato la cinquantina o se abbiano tutti 20 anni come Wolfgang Van Halen. Degna di nota è la batteria che come in tutto l’album fa cose tecnicamente pregevoli e ha dei suoni notevoli, in piena tradizione col migliore Alex Van Halen.
Honeybabysweetiedoll appare la più sperimentale del lotto, stile album “Women And Children First”. Dopo i primi 25 secondi affidati a rumori e voci di sottofondo, parte un riff orientaleggiante, dove si districa bene la voce di David Lee Roth.
The Trouble With Never, mid-tempo di presa immediata, parte con un bel riff all’unisono di basso e chitarra. Il ritornello subito si ficca in testa e anche le strofe appaiono convincenti.
Outta Space è un hard rock dritto per dritto col riff iniziale molto glam ottantiano. Peccato solo per la performance di David Lee Roth, poco incisiva sugli acuti.
Con Stay Frosty immediatamente veniamo rimandati ai brani di vecchia produzione “Ice Cream Man” e “Take Your Whiskey Home”. Chitarra acustica e voce gigiona che fa da padrona. Come in “Ice Cream Man” arriva poi la parte rock, fino al solo, davvero convincente. Uno dei pezzi migliori dell’album.
In Big River, dopo il breve intro di chitarra pulita, parte un riff distorto con basso e batteria tutt’uno possenti. Wolfgang Van Halen non pare far pesare la mancanza di Michael Anthony, almeno in studio, in tutto il disco interpreta il ruolo di bassista solido senza fronzoli. Che poi dal vivo non ci stia per nulla a livello di presenza col resto della band è un altro discorso.
Infine con Beats Workin’ si chiude il lavoro. Altro riff old style, sembra di essere in pieno nel periodo Van Halen dei primi due album.
Niente di nuovo sotto il sole quindi, questo album potrebbe essere benissimo accostato agli altri della loro produzione fine ’70/ inizio ’80, anche a livello qualitativo, a parte ovviamente l’inarrivabile primo omonimo. La band appare in forma, adesso bisognerà aspettare la riprova del live, chissà se sarà la volta buona per vederli in azione anche in Europa. Qualcuno lamenterà scarse innovazioni da una band che ci in passato ci aveva sempre abituati a delle sorprese, qualcun altro griderà al miracolo di risentire i redivivi Van Halen così ancorati al passato come se tutti questi anni non fossero mai passati. Non ci saranno grosse hit alla Jump, mega assoli alla Eruption, riff indimenticabili come in Ain’t Talkin’ About Love, ma l’album complessivamente risulta piacevole e compatto. Un positivo e gradito ritorno.